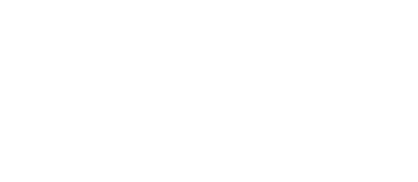Maurizio Iovinelli / 02 ottobre 2025
Commento n. 011/2025 NS
La politica industriale, a lungo marginalizzata nell’Unione europea (UE) a causa di un approccio orizzontale, della centralità del principio di concorrenza e della ferrea disciplina sugli aiuti di Stato, è tornata oggi al centro del dibattito pubblico. Infatti, i fallimenti di mercato provocati dalla degenerazione della globalizzazione, le crisi delle catene globali del valore, la competizione tecnologica con la Cina e gli Stati Uniti, le strategie geoeconomiche come, ad esempio, l’autonomia strategica aperta dell’UE e la necessità di accelerare la transizione verde e digitale hanno reso evidente l’urgenza di un intervento comune.
Gli Important Projects of Common European Interest (IPCEI), nonostante fossero disciplinati già dall’articolo 155 del Trattato sulla Comunità economica europea del 1957, hanno preso forma solamente a partire dagli ultimi anni e consentono agli Stati membri dell’UE di finanziare grandi progetti transnazionali, favorendo, in tal modo, la crescita economica e la competitività europea. Per essere più precisi, gli Stati che prendono parte a un importante progetto di comune interesse europeo possono beneficiare di un regime derogatorio in tema di sovvenzioni pubbliche, purché gli investimenti previsti contribuiscano significativamente alla competitività europea, abbiano un carattere innovativo e generino benefici diffusi per l’economia europea.
Allo stato attuale, sono stati attivati 11 IPCEI che cadono principalmente nel perimetro della digitalizzazione e della transizione ecologica e che vedono nell’insieme la partecipazione di 23 Stati membri dell’UE e 257 aziende europee; la Commissione europea ha approvato sovvenzioni statali per un valore complessivo di 37,6 miliardi di euro e stima una cifra di investimenti privati pari 66,8 miliardi di euro. Nel 2021, su proposta della Commissione europea, è stato istituito il Joint European Forum for IPCEI (JEF-IPCEI), ossia una piattaforma di coordinamento tra la Commissione stessa, gli Stati membri e le imprese coinvolte in ciascun progetto di comune interesse europeo. Il JEF-IPCEI non si limita a individuare nuove aree strategiche in cui poter intervenire; esso ha il compito, da un lato, di monitorare e valutare gli IPCEI già approvati e, dall’altro, di favorire sia un’allocazione efficiente delle risorse sia la diffusione di best practices e di informazioni di carattere procedurale e operativo. In aggiunta, il JEF-IPCEI mira anche a promuovere una maggiore trasparenza circa i criteri di selezione per i singoli progetti in modo tale da aumentarne l’attrattività.
Nonostante i buoni propositi, il JEF-IPCEI presenta, tuttavia, limiti significativi per tre ragioni. In primo luogo, il coordinamento offerto dalla piattaforma rimane piuttosto frammentato. Secondariamente, il forum non dispone di poteri esecutivi vincolanti. Infine, esso non possiede un budget autonomo: infatti, i progetti sono finanziati in buona misura dai bilanci nazionali e ciò, oltre a generare dei rischi in termini di esclusione degli Stati più piccoli che dispongono di poche risorse, può anche portare all’insorgenza della selezione avversa. Di conseguenza, una parte della letteratura accademica ha evidenziato come questi limiti riducono, di fatto, l’efficienza complessiva dello strumento, portando, al contrario di quanto previsto, a un utilizzo subottimale delle risorse. Inoltre, se è vero che le PMI rischiano l’esclusione dagli IPCEI a causa dell’oberante carico amministrativo e burocratico, è altrettanto vero che la scarsa efficacia del JEF-IPCEI può addirittura compromettere la leale concorrenza nel mercato interno dell’UE.
Negli Stati Uniti, nonostante l’assenza di una tradizione pianificatrice, il ruolo del governo federale e delle sue agenzie nell’elaborazione della politica industriale è cresciuto progressivamente. Dai programmi avviati nel Secondo dopoguerra fino a quelli più recenti come il Chips and Science Act e l’Inflation Reduction Act, la Casa Bianca e i vari Dipartimenti hanno dimostrato una forte capacità di orientare le risorse verso settori strategici. Ancorché non ci sia un framework del tutto unitario, la politica industriale statunitense si è sviluppata mediante l’implementazione di programmi federali settoriali; dal punto di vista della governance, questi ultimi si differenziano dagli IPCEI per due fattori determinanti, vale a dire l’istituzione di agenzie specializzate come, ad esempio, la Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA) o la National Science Foundation, che patrocinano e cofinanziano investimenti ad alto rischio promuovendo, contestualmente, modelli di innovazione del tipo mission-oriented, e l’esistenza di un bilancio federale integrato che, da un lato, garantisce una copertura finanziaria adeguata e, dall’altro, limita i rischi di selezione avversa e di esclusione sia degli Stati sia delle PMI.
In definitiva, nell’UE la governance degli IPCEI mediante il JEF risulta essere debole: la politica industriale europea, ammesso che la si possa considerare a tutti gli effetti comunitaria, è sostanzialmente il frutto di una cooperazione intergovernativa e se, da un lato, le risorse finanziarie a disposizione sono insufficienti (specie se le si confronta con le disponibilità del governo statunitense), dall’altro, è opportuno sottolineare nuovamente come l’assenza di poteri esecutivi vincolanti limita la capacità sia della Commissione europea sia del JEF-IPCEI nel direzionare gli investimenti verso i settori strategici e ad alto valore aggiunto. La governance e la peculiare natura degli IPCEI hanno spinto Fontana, Vannuccini, Buti e Papacostantinou a classificarli come beni pubblici europei per aggregazione: gli IPCEI si caratterizzano, infatti, per una compartecipazione delle istituzioni di Bruxelles e delle autorità nazionali tanto nella fase di finanziamento quanto in quella di attuazione; in aggiunta, la classificazione come beni pubblici europei per aggregazione risulta essere particolarmente appropriata per la seconda ondata degli IPCEI, vale a dire per quei progetti cofinanziati con le risorse del Next Generation EU (NGEU).
Al contrario, negli Stati Uniti la presenza di una regia federale e di agenzie specializzate dotate di poteri esecutivi vincolanti, la disponibilità rimarchevole di risorse finanziarie associate a una capacità decisionale rapida e orientata a priorità nazionali risultano in una governance piuttosto forte. Inoltre, programmi come la creazione di hub tecnologici regionali sono indicativi del tentativo da parte dell’amministrazione federale di distribuire geograficamente i benefici, favorendo, dunque, un processo di convergenza dei vari indicatori di benessere economico tra i diversi Stati federati. Cionondimeno, la governance della politica industriale statunitense non è certamente immune da criticità: la presenza di grandi multinazionali meglio equipaggiate comporta talvolta il rischio che queste riescano a catturare la maggior parte delle risorse e, allo stesso tempo, la governance centralizzata si presta più e meglio a episodi di corruzione, concussione e collusione.
Sebbene nel maggio del 2023 la Direzione Generale per la concorrenza della Commissione europea (DG COMP) abbia elaborato il Code of good practices for a transparent, inclusive, faster design and assessment of IPCEIs, la strada verso una politica industriale comune rimane ancora lunga e irta di ostacoli perlopiù di natura politica e istituzionale. Il Rapporto Much More Than a Market – Speed, Security, Solidarity (meglio noto come Rapporto Letta presentato nell’aprile del 2024) e il Rapporto The Future of European Competitiveness (più conosciuto come Rapporto Draghi del settembre 2024), seppur incentrati su temi diversi ma complementari, hanno sottolineato la necessità di rafforzare la sovranità economica europea creando gli strumenti atti a sostenere la competitività industriale. Se il Rapporto Letta ha evidenziato l’importanza di costituire un’unione degli investimenti per finanziare soprattutto la transizione verde e digitale, contribuendo, in tal modo, a superare l’home bias che ancora contraddistingue i portafogli degli investitori europei, il Rapporto Draghi non ha mancato di precisare quanto sia fondamentale disporre di un bilancio europeo integrato che possa garantire risorse finanziarie adeguate su base annua.
Considerata l’insufficiente capacità del JEF-IPCEI nell’orientare e nel razionalizzare gli investimenti verso settori strategici al fine di gettare le basi per una politica industriale comune e poiché pare inverosimile una revisione dei trattati in tempi brevi, l’istituzione di un semestre europeo per la politica industriale potrebbe rappresentare un passo concreto che va nella direzione di quanto auspicato nei Rapporti Letta e Draghi. In quest’ottica, così come il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio dell’UE è stato istituito nel 2010 sulla base degli articoli 121 e 148 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) all’indomani della crisi finanziaria globale e quasi allo scoppio della crisi del debito sovrano nell’Eurozona, allo stesso modo un semestre europeo per il coordinamento della politica industriale, dotato anch’esso delle country specific recommendations di carattere più vincolante, potrebbe ovviare alla mancanza di un vero centro politico in grado, come negli Stati Uniti, di direzionare con lungimiranza ed efficienza gli investimenti nei territori dell’Unione. Inoltre, un tale semestre industriale europeo avrebbe il vantaggio di rafforzare la trasparenza e la prevedibilità delle decisioni, fornendo un quadro stabile per gli investitori privati. Di fronte a un sistema internazionale sempre più complesso e conflittuale, questo strumento potrebbe trasformare la politica industriale europea in una leva capace di rispondere alle sfide globali e di promuovere una crescita più sostenibile, equilibrata e inclusiva.
In conclusione, il confronto tra il JEF-IPCEI e la governance della politica industriale statunitense rivela la necessità per l’UE di compiere un salto qualitativo nella gestione degli importanti progetti di comune interesse europeo. Solo dotandosi di strumenti vincolanti, di risorse autonome e sufficienti e di una visione strategica condivisa, l’UE potrà affrontare efficacemente la competizione globale e garantire che i benefici dell’innovazione siano distribuiti equamente tra i suoi Stati membri.
*Junior Visiting Fellow FCSF

 It
It  En
En