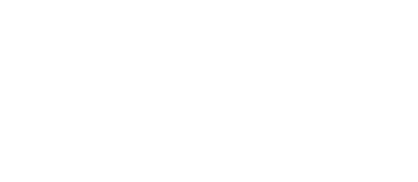Commento n. 008/2025 NS
Le misure di politica economica adottate nei primi mesi dell’Amministrazione Trump sono certamente inusuali rispetto alla tradizione americana. Non si tratta però di scelte irrazionali, bensì di un disegno che lega due fronti apparentemente separati: da un lato il divieto di istituire una Central Bank Digital Currency (CBDC) e la legalizzazione delle stablecoins; dall’altro le pressioni esercitate sulla Federal Reserve per ridurre i tassi. Due canali che, a ben vedere, rispondono alla stessa logica.
Uno dei primi atti di Trump come Presidente degli Stati Uniti è stato il divieto di promuovere e istituire qualsiasi CBDC: monete digitali emesse dalle banche centrali, basate su tecnologie DLT (Distributed Ledger Technology) o infrastrutture digitali centralizzate, spesso ispirate ai meccanismi blockchain e garantite dall’autorità monetaria. Le CBDC rappresentano la risposta delle autorità di politica monetaria alla crescente domanda di mercato di strumenti per transazioni a costo marginale zero (come le criptovalute), che però si caratterizzano per elevata volatilità e tracciabilità limitata, dunque opache e potenzialmente al servizio dell’economia sommersa. Esperimenti avanzati in questa direzione sono già in corso in Cina e India. Anche la BCE, con la consueta prudenza che contraddistingue le istituzioni europee, sta da tempo studiando l’euro digitale. In netta controtendenza, lo scorso luglio Trump ha fatto approvare una normativa che legalizza le stablecoins: valute digitali ancorate a un altro asset, a sua volta garantite da un’autorità monetaria (il 90% di quelle esistenti è oggi legate al dollaro).
La ragione principale di questa mossa è rilanciare il ruolo del dollaro come moneta-àncora del sistema internazionale dei pagamenti. Promuovendo le stablecoins, gli emittenti sono infatti obbligati a detenere maggior collaterale nella moneta-àncora (dollari), consentendo così al Tesoro statunitense di beneficiare di una domanda significativa e costante di titoli pubblici con cui finanziare l’aumento indefinito della spesa federale: difesa, sicurezza, innovazione, in un’ottica di confronto-scontro con la Cina, vero competitor internazionale degli Stati Uniti.
Il costo di questa scelta è l’aumento del potenziale rischio sistemico. Come nel caso dei derivati che innescarono la crisi finanziaria del 2008, le stablecoins sono ancorate ad asset formalmente stabili, ma niente e nessuno garantisce comportamenti virtuosi (copertura del capitale) da parte degli istituti di emissione. Né si può escludere che la valuta di riferimento subisca una crisi di fiducia e perda improvvisamente valore, come accaduto nei primi mesi dell’anno, quando i rendimenti sui titoli del Tesoro statunitense si sono impennati pericolosamente.
Potrebbe esserci un altro rischio: che queste mosse aprano la strada all’emissione di strumenti concorrenti basati su analoga tecnologia blockchain e logiche peer-to-peer (ossia non intermediati da autorità centrali), favorendo la creazione di una stablecoin ancorata all’euro o agli SDR, la moneta-paniere del FMI composta da dollaro, euro, yuan, yen e sterlina. Quest’ultima risulterebbe molto meno soggetta agli umori mutevoli del mercato. È in questo quadro che vanno lette le pressioni di Trump sull’Europa, esercitate attraverso il ricatto dell’abbandono della difesa e sicurezza comune, e la delegittimazione sistematica delle istituzioni internazionali.
Per comprendere appieno perché sul ruolo del dollaro si gioca il futuro degli USA (e dell’assetto finanziario e di potere globale) è utile osservare quello che è avvenuto negli ultimi mesi alla Fed, oggetto di pressioni crescenti da parte di Trump e Bessent (Ministro del Tesoro) sul Governatore Powell per una diminuzione dei tassi. Una manovra non tanto finalizzata a rilanciare investimenti e consumi, oggi più legati alle aspettative che al costo del denaro, quanto a ridurre il peso del servizio del debito, ormai al 3,2% del PIL. Una voragine che assorbe circa un trilione di dollari l’anno, ossia quanto l’intera spesa per la difesa.
Da qui le dimissioni improvvise, il 1° agosto, di Adriana Kugler dal Board della Fed – già nominata da Biden e considerata vicina alla linea rigorista – e la nomina, ancora in attesa di conferma al Senato, di Stephen Miran, autore della strategia presidenziale sul dollaro e sui dazi e già a capo del Council of Economic Advisors.
Gli Stati Uniti sono dunque in una trappola del debito: devono rilanciare la propria leadership globale, ma per farlo devono spendere. Ciò avviene in un momento in cui il livello della spesa e del deficit ha già sollevato dubbi sulla sostenibilità. L’unico modo per rendere sostenibile l’insostenibile è costringere il resto del mondo a finanziare la spesa americana: attraverso i dazi, che portano entrate fiscali significative ma non risolutive; attraverso le stablecoins, che creano domanda indiretta di dollari e T-bill; e attraverso la pressione sulla Fed, funzionale a mantenere sotto controllo il costo del debito con una svalutazione controllata della valuta. Una scommessa complessa, che si regge sulla credibilità dell’atteggiamento assertivo di Trump, convinto di poter giocare la carta della forza politica e militare per reimporre il ruolo cruciale degli Stati Uniti e del dollaro. Il rischio che la manovra fallisca è oggi elevato: non per le resistenze degli alleati, che hanno già dimostrato ampia acquiescenza, ma per la possibile reazione coordinata di altri attori globali, come Cina, India, Brasile e Sudafrica. O per la risposta dei mercati.
La decentralizzazione in corso dell’emissione di moneta, che farebbe felice Hayek (come ricordato nel suo The Denationalization of Money del 1976), insieme alla pericolosa delegittimazione delle autorità di politica monetaria come regolatori indipendenti dal potere politico, rischia di accrescere il livello d’incertezza, vulnerabilità e rischio dell’intero sistema finanziario globale.
*Junior Visiting Fellow Fondazione CSF

 It
It  En
En