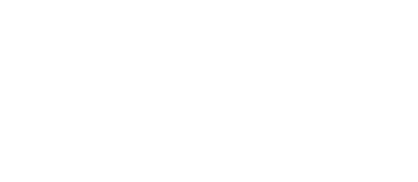Commento n. 007/2025 NS
La visita congiunta del 27 agosto 2025, del Presidente francese Emmanuel Macron, del Cancelliere tedesco Friedrich Merz e del Primo ministro polacco Donald Tusk a Chișinău per la commemorazione dei 34 anni dall'adozione della Dichiarazione di Indipendenza dall'Unione Sovietica, può essere percepita come un messaggio rivolto all’intero continente: l’Europa non può più permettersi “zone grigie” di vulnerabilità, né Paesi sospesi tra Bruxelles e Mosca.
Il gesto di sostegno alla Presidente Maia Sandu è la prova che la Moldavia non è più una periferia dimenticata, ma un tassello cruciale nella definizione geopolitica dell’Unione europea. Tuttavia, dietro la forza simbolica di questa visita restano numerosi interrogativi: l’UE ha davvero la capacità di tradurre in fatti la promessa di adesione entro il 2027 o rischia di ripetere gli errori compiuti nei Balcani occidentali, dove le aspettative si sono trasformate in delusione?
Il traguardo fissato è chiaro: portare la Moldavia nell’UE entro il 2027. Come ha ricordato Gert Jan Koopman, Direttore generale della DG Neighbourhood & Enlargement Negotiations, il 2025 è l’anno in cui “intendiamo aprire tutti i capitoli negoziali”. Due le condizioni indispensabili: completare il lavoro tecnico “entro settembre” e ottenere il voto unanime del Consiglio dell’UE per l’apertura formale dei negoziati. È proprio qui che il percorso di integrazione potrebbe incontrare l’ostacolo più difficile: l’unanimità dei 27 resta il vero tallone d’Achille della politica di allargamento.
Il punto è che l’obiettivo rischia di restare più retorico che realistico. La Moldavia è esposta a pressioni costanti della Russia: presenza militare in Transnistria, dipendenza energetica e campagne di disinformazione che Sandu ha denunciato esplicitamente in campagna elettorale e che lo stesso Merz ha confermato come “attacchi quotidiani contro la democrazia moldava”. Sul piano del sostegno materiale, l’UE ha cercato di definire un metodo di accompagnamento. Nel marzo 2025 il Parlamento europeo ha approvato lo Strumento per la riforma e la crescita della Moldavia, del valore di 1,9 miliardi di euro, il più grande pacchetto di assistenza dall’indipendenza del Paese (Parlamento europeo, 2025). Sul fronte della sicurezza, la Moldavia è divenuta il secondo maggiore beneficiario del Fondo europeo per la pace, con 197 milioni di euro stanziati per il periodo 2021-2025, a dimostrazione che Bruxelles percepisce la fragilità del Paese come una questione di sicurezza continentale.
A livello politico, la scelta del formato Francia-Germania-Polonia (triangolo di Weimar) intende rilanciare un nucleo di guida, richiamando i precedenti storici che portarono a salti qualitativi nell’integrazione. Ma il contesto odierno appare molto più frammentato: se da un lato prevale la consapevolezza che senza allargamento l’UE rischia di perdere influenza, dall’altro molti governi temono un ampliamento che, senza riforme istituzionali interne, aggraverebbe l’impasse decisionale.
Il 2025 è presentato come data-simbolo di svolta. In teoria, la fissazione di una scadenza è ciò che distingue una promessa da un impegno concreto, come dimostrò l’introduzione dell’euro. Ma nel caso moldavo il calendario appare fragile. Diversamente dal 2004, quando l’allargamento fu sostenuto da un consenso politico forte e da condizioni di sicurezza relativamente stabili, oggi il contesto internazionale è segnato da guerra e instabilità. Se la scadenza dovesse slittare, il rischio sarebbe quello di alimentare il disincanto dell’opinione pubblica moldava e offrire spazio a forze euroscettiche e filorusse. Il 2004 dimostrò che l’UE è capace di integrare rapidamente Paesi usciti dal blocco sovietico, rafforzando la stabilità dell’Europa centrale. Ma oggi è doveroso ammettere che replicare quel modello è molto difficile. In qualche modo, più vicino al caso moldavo sembra proprio il percorso dei Balcani occidentali, dove vent’anni di promesse non mantenute hanno prodotto stagnazione e frustrazione, aprendo la porta a influenze esterne.
In conclusione, la visita a Chișinău manda comunque un messaggio chiaro a Mosca: l’UE non intende abbandonare il suo vicinato orientale. Macron ha parlato di “storica opportunità” e ha ricordato che l’Unione europea “non è in alcun modo l’Unione Sovietica, ma una comunità di pace e prosperità”. Tuttavia, senza progressi sulla difesa comune e sul superamento dei veti nazionali, Bruxelles rischia di non avere gli strumenti per sostenere davvero Chișinău in caso di escalation. D’altro canto, anche la Moldavia deve lavorare molto internamente per permettere che il sogno europeo diventi realtà: deve consolidare lo Stato di diritto, rafforzare la resilienza economica ed energetica e affrontare la questione transnistriana.
Qui torna utile il richiamo di Jacques Delors: nel 1985, presentando l’idea del grande mercato interno, ricordava che “bearing past experience in mind, we proposed a method of attaining this objective, a method based on a timetable”. Oggi la Moldavia mette l’UE di fronte a questa regola. Se Bruxelles saprà rispettare le promesse secondo le tempistiche, dimostrerà di essere una vera comunità politica capace di assumere responsabilità storiche. Ma se prevarranno esitazioni e divisioni, Chișinău rischia di diventare il simbolo delle ambizioni incompiute dell’Unione, più che il segno della sua forza.
*Junior Visiting Fellow Fondazione CSF

 It
It  En
En