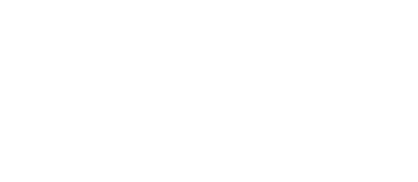Nicoletta Pirozzi / 3 novembre 2025
Commento n. 013/2025 NS
Il nuovo panorama di sicurezza internazionale e l’atteggiamento dell’amministrazione statunitense hanno trasformato la realizzazione dell’autonomia strategica dell’UE da un’ambizione a una necessità. Viste le ambiguità del presidente Trump sul conflitto ucraino e sulla stessa difesa dell’Europa nel quadro NATO, realismo e prudenza imporrebbero all’UE di dotarsi al più presto di strumenti autonomi per garantire un adeguato sostegno a Kyiv di fronte all’aggressione russa e per dissuadere ulteriori minacce russe sul suolo europeo.
Per rispondere a questa urgenza, la Commissione europea ha lanciato l’agenda Readiness 2030, che mira a mobilitare fino a 800 miliardi di euro per la difesa, in linea con le raccomandazioni del Rapporto Draghi. Il primo pilastro dell’agenda è costituito dallo Strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE), che mira a sostenere gli Stati membri che desiderano investire nella produzione industriale nel settore della difesa mediante appalti comuni con prestiti fino a 150 miliardi di euro. Allo stesso tempo, al Vertice NATO del 2025 gli Alleati si sono impegnati a investire il 5% del PIL annuo nei requisiti fondamentali di difesa, nonché nella spesa per la sicurezza e la difesa entro il 2035 (NATO, 2025). Tuttavia, gli sforzi intrapresi a livello nazionale rischiano di rimanere frammentati e, in ultima analisi, di compromettere il tentativo di dotare l’Europa di una capacità strategica.
Partendo da ciò, la Commissione europea e l’Alto Rappresentante hanno proposto una Defence Readiness Roadmap per sviluppare e dispiegare “le capacità e la prontezza militare necessarie per la guerra moderna” entro il 2030. L’obiettivo dell’iniziativa è stimolare gli investimenti, ma allo stesso tempo garantire che ciò avvenga in modo collaborativo tra gli Stati membri e a favore dello sviluppo di capacità europee. Essa mira inoltre a razionalizzare i diversi processi in corso relativi allo sviluppo delle capacità nell’UE, sia a livello intergovernativo che sovranazionale. L’obiettivo finale è che gli Stati membri acquistino congiuntamente almeno il 40% delle loro capacità di difesa entro il 2030.
La Roadmap inizia con una panoramica, elaborata dallo Stato Maggiore Militare dell’UE (EUMS), dello stato attuale delle capacità degli Stati membri e dei loro obiettivi in questo settore, comprendenti lo sviluppo di nove aree di capacità critiche individuate dalle capitali nazionali tenendo conto degli obiettivi della NATO e delle esigenze dell’Ucraina. Tale panoramica dovrebbe essere integrata nella Coordinated Annual Review on Defence (CARD), gestita dall’Agenzia europea per la difesa (EDA) e regolarmente esaminata dai Capi di Stato maggiore della difesa. Ma la Roadmap prevede anche un ruolo per la Commissione e per l’Alto Rappresentante, i quali dovrebbero presentare un rapporto annuale sulla sua attuazione.
Il compito di sviluppare le capacità critiche rimane nelle mani degli Stati membri attraverso Collective Capability Coalitions, guidate da uno o più di essi, con l’obiettivo di realizzare progetti collaborativi. Tuttavia, una task force comprendente anche la Commissione europea e l’Alto Rappresentante dovrebbe supportare il lavoro delle coalizioni, mentre la Commissione dovrebbe garantire il collegamento con gli strumenti di finanziamento dell’UE come SAFE. Inoltre, la Roadmap prevede il lancio di quattro progetti faro paneuropei: il European Drone Wall per contrastare e dominare la guerra dei droni, l’Eastern Flank Watch per rafforzare la difesa dei confini orientali dell’Unione, l’Air Defence Shield, lo scudo aereo e antimissile del continente, e il Defence Space Shield per proteggere le infrastrutture spaziali e le comunicazioni strategiche.
Le tensioni tra istituzioni dell’UE e Stati membri che questa iniziativa inevitabilmente genera sono sintomatiche di un ostacolo più ampio sulla via dell’autonomia strategica europea: la mancanza di una visione chiara sugli obiettivi ultimi di un’Unione della difesa e sull’assetto istituzionale necessario per realizzarla. Quanto agli obiettivi, vi sono almeno alcune indicazioni sui requisiti minimi imposti dall’attuale contesto di sicurezza: sviluppare capacità di deterrenza europee, incluse capacità strategiche autonome dagli Stati Uniti per riequilibrare i rapporti di forza all’interno della NATO, e fornire garanzie di sicurezza ai partner attraverso una forza di intervento europea credibile.
Sul piano istituzionale, l’esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che una sovranazionalizzazione della difesa europea è fuori portata. Essa richiederebbe una riforma dei Trattati che gli Stati membri non sono disposti ad affrontare. Allo stesso tempo, procedere a 27 per consenso negli organi intergovernativi dedicati si è rivelato un vicolo cieco, a causa delle persistenti divergenze strategiche e delle priorità politiche specifiche dei governi nazionali. Pertanto, sembra che l’unica via realistica per avanzare in questo settore sia attraverso una cooperazione differenziata tra gruppi più ristretti di Stati membri.
La Defence Readiness Roadmap adotta questo approccio e affida alle coalizioni di Stati membri il compito di sviluppare le capacità critiche. Allo stesso tempo, l’unico tentativo – sebbene ancora contestato e dal destino incerto – di dispiegare una forza di intervento per garantire la sicurezza dell’Ucraina proviene dalla “coalizione dei volenterosi” guidata da Regno Unito e Francia. Queste forme di cooperazione ad hoc – sia attorno a progetti di sviluppo di capacità sia a iniziative operative mirate – sono positive fintanto che raggiungono i loro obiettivi. Tuttavia, comportano anche rischi di eccessiva frammentazione e mancanza di legittimità e non rappresentano un percorso stabile verso l’integrazione nel campo della difesa, che consentirebbe all’UE di decidere e agire autonomamente.
Un percorso verso una reale integrazione per la creazione di un’Unione della Difesa richiederebbe innanzitutto la creazione di un nucleo duro di Stati membri che assumano impegni chiari e duraturi per sviluppare capacità comuni con risorse finanziarie adeguate e che si impegnino a essere pronti a intervenire con forze congiunte quando necessario. Questa sembra l’unica soluzione praticabile tra due alternative subottimali: lasciare che gli Stati membri spendano i bilanci nazionali per la difesa, aumentati dai prestiti SAFE, senza alcuna cooperazione o coordinamento (un rischio concreto, dato che SAFE prevede scarsa condizionalità che incentivi alla collaborazione); oppure lasciare che la Commissione europea si occupi della pianificazione dello sviluppo delle capacità militari, senza mandato giuridico o legittimità politica, e soprattutto senza la possibilità di acquistare e rendere operative tali capacità.
Per procedere in questa direzione, non è necessario reinventare la ruota aggiungendo nuove strategie, libri bianchi, roadmap o task force, poiché i Trattati già forniscono all’UE gli strumenti necessari. La Cooperazione Strutturata Permanente (PESCO), lanciata nel novembre 2017 con la partecipazione di 25 Stati membri e con l’aggiunta della Danimarca nel 2023, va proprio in questa direzione. PESCO è uno strumento di cooperazione differenziata previsto dai Trattati, ed è istituzionalmente e politicamente integrato nell’architettura dell’UE, caratteristica che almeno riduce il rischio di frammentazione e mancanza di legittimità. Attualmente, PESCO è strutturata su due livelli di governance: un livello generale nel Consiglio Affari Esteri, dove i paesi membri decidono a maggioranza qualificata, e un livello modulare a livello di progetto. Il fondamento istituzionale è individuato dai Trattati nel ruolo dell’Alto Rappresentante/Vicepresidente della Commissione europea, in qualità di Presidente del Consiglio Affari Esteri e Capo dell’EDA, che funge da segretariato di PESCO insieme al SEAE.
Finora, la sua missione è rimasta in gran parte incompiuta. A causa dell’ampia partecipazione, la cooperazione politica tra i paesi membri si è diluita e PESCO è stata drasticamente de-prioritizzata nel corso degli anni. Inoltre, i progetti realizzati nel quadro di PESCO hanno raramente colmato lacune critiche, essendo per lo più poco ambiziosi, sottofinanziati e non coordinati. Tuttavia, l’iniziativa politica intrapresa da un nucleo duro di Stati membri per ripensare e rilanciare PESCO potrebbe rappresentare un punto di svolta in grado di portare a un’integrazione più profonda nel settore della difesa.
Questa iniziativa dovrebbe partire dal recupero dello scopo originario di PESCO, come stabilito dal Trattato sull’Unione europea (TUE), che definisce i criteri di accesso e chiarisce che PESCO è riservata agli Stati membri le cui capacità militari soddisfano criteri più elevati e che hanno assunto impegni più vincolanti tra loro in questo ambito, in vista delle missioni più impegnative (art. 42.6 TUE). Ciò significa che la nuova PESCO dovrebbe essere guidata da un gruppo ristretto di Stati membri disposti e in grado di utilizzare il quadro dell’UE per effettuare investimenti significativi nella difesa, condividere capacità critiche e agire insieme quando necessario.
Inoltre, il TUE definisce le procedure del processo decisionale, introducendo per la prima volta il voto a maggioranza qualificata nel settore della difesa (art. 46 TUE), un potenziale grande passo avanti in termini di efficacia e rapidità delle decisioni da adottare. Il Protocollo allegato al Trattato di Lisbona chiarisce anche i due obiettivi prioritari per ogni Stato partecipante a PESCO: sviluppare più intensamente le proprie capacità di difesa attraverso il potenziamento dei contributi nazionali e partecipare, a livello nazionale o come componente di forze multinazionali, ai gruppi tattici dell’UE (Protocollo 10 TUE).
Ciò comporta che gli Stati partecipanti sviluppino progetti di capacità condivisi, in particolare per le principali piattaforme e per gli abilitatori strategici (trasporti, ecc.), che, ove possibile, devono essere acquistati e gestiti congiuntamente. La nuova PESCO potrebbe diventare la spina dorsale della Defence Readiness Roadmap, assumendosi la responsabilità dei progetti più impegnativi, inclusi quelli faro. Questa è probabilmente la migliore opzione per collegare meglio il ruolo crescente della Commissione europea nello sviluppo dell’industria della difesa dell’UE con la responsabilità degli Stati membri per la pianificazione militare, l’approvvigionamento delle capacità e il dispiegamento operativo.
Integrare PESCO nella Roadmap rafforzerebbe il suo collegamento con il processo di sviluppo delle capacità dell’UE, guidato dagli Stati membri e dall’EDA e regolarmente rivisto attraverso il CARD. Rinnovare PESCO potrebbe anche aiutare il Consiglio europeo nella sua ambizione di rafforzare e rilanciare l’EDA, anche al fine di riequilibrare il potere della Commissione europea. Per far funzionare PESCO, sarebbe necessario garantirle l’accesso a risorse finanziarie adeguate, inclusi SAFE, la European Defence Industrial Strategy (EDIP) e il Fondo europeo per la difesa (EDF), nonché altri strumenti finanziari nel prossimo Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2035.
Per adempiere pienamente alla sua missione, la nuova PESCO dovrebbe anche disporre di una capacità di intervento. Pertanto, i membri dovranno condividere una forza operativa in grado di condurre autonomamente operazioni al di fuori dei confini dell’UE, per la quale dovranno essere chiarite dimensione, compiti e struttura di governance. In futuro, gli sforzi attualmente condotti al di fuori del quadro dell’UE, come la “coalizione dei volenterosi” per l’Ucraina, dovrebbero essere integrati nella nuova PESCO, con l’obiettivo di connetterli alle istituzioni dell’UE e allinearli con gli obiettivi di politica estera perseguiti a livello europeo. Dovrebbero essere individuati meccanismi adeguati per garantire e facilitare la partecipazione di paesi terzi come il Regno Unito, basandosi sulle lezioni apprese dal progetto sulla Military Mobility.
Rafforzare PESCO non è in contrasto con la prospettiva di un partenariato più stretto tra UE e NATO, né con le legittime aspettative degli Stati membri di mantenere la NATO come pilastro della difesa europea. L’obiettivo principale sarebbe la ricerca di cooperazione e coerenza tra Unione europea e NATO, pur con la necessaria autonomia. A livello operativo, il nucleo europeo nel settore della difesa delineato dalla prospettiva di integrazione differenziata diventerebbe il pilastro europeo della NATO, trasformando l’Alleanza da un’organizzazione di 32 membri in un’alleanza nordamericana-europea. L’Alleanza risulterebbe più equilibrata e reciprocamente vantaggiosa per Stati Uniti ed europei, aggiungendo abilitatori strategici europei e una capacità operativa autonoma nei casi in cui gli Stati Uniti non intendano intervenire.
Tuttavia, deve essere chiaro che la PESCO così com’è stata finora implementata non sarebbe in grado di assolvere a questo scopo. A meno che non diventi permanente per un nucleo duro di Stati membri, strutturata attraverso una serie coerente di progetti di sviluppo congiunti e in grado di attuare una vera politica di difesa, non potrà essere definita PESCO. Solo soddisfacendo questi requisiti, PESCO consentirà di istituire una vera difesa europea attraverso un modello di integrazione differenziata.
*Consigliere Fondazione CSF

 It
It  En
En