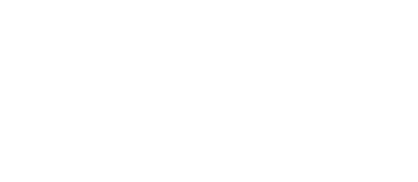Federico Fabbrini / 23 luglio 2025
Commento n. 005/2025 NS
Il 17 luglio 2025 la Germania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno concluso nel sobborgo londinese di Kensington un Trattato bilaterale di amicizia e collaborazione. Il trattato di 30 articoli è giuridicamente vincolante ed entrerà in vigore in seguito alla ratifica in conformità alle norme costituzionali inglesi e tedesche. Il trattato di Kensington è stato definito dalla stampa britannica come un accordo storico, in quanto costituisce il primo trattato bilaterale tra la Germania e il Regno Unito dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. In realtà, il trattato fa seguito ad un accordo bilaterale settoriale nel campo della difesa concluso dai Ministri della Difesa della Germania e del Regno Unito nell’ottobre 2024. In aggiunta, esso è parte di un più ampio mosaico di intese che il Governo Starmer ha recentemente concluso per ricostruire la sua relazione post-Brexit con i vicini europei, in un momento in cui la relazione transatlantica è in crisi e la guerra di aggressione russa all’Ucraina continua: tra queste spiccano l’accordo concluso tra Regno Unito e Unione europea (UE) il 19 maggio 2025, la cd. Partnership sulla sicurezza e la difesa, e la Dichiarazione di Northwood tra Regno Unito e Francia sul coordinamento nel campo della deterrenza nucleare, raggiunta la settimana precedente, il 10 luglio 2025.
Il trattato di Kensington tuttavia, solleva una serie di problemi giuridici. Da un lato esso mette in luce a contrario le limitazioni che si pongono nel rapporto tra Regno Unito e UE; dall’altro esso espone alcuni delle questioni che emergono laddove stati membri dell’UE agiscono autonomamente e unilateralmente nelle relazioni internazionali con paesi terzi.
Dal punto di vista contenutistico il trattato di Kensington copre una ampia gamma di materie. Nello specifico, il capitolo 1 regolamenta la cooperazione bilaterale tra Germania e Regno Unito nel campo delle relazioni internazionali; il capitolo 2 nel campo della difesa; il capitolo 3 nel campo della sicurezza interna, giustizia e politica migratoria; il capitolo 4 nel capo della crescita economica e della competitività; il capitolo 5 nel campo della resilienza delle società aperte; e il capitolo 6 nelle politiche climatica, energetica, ambientale e agricola. Le disposizioni istituzionali sulle modalità della cooperazione sono contenute invece in un conclusivo capitolo 7, che prevede forme di incontro annuali a livello di Ministri degli Esteri e biannuali a livello di Capi di governo, con la possibilità per le parti di modificare il trattato di mutuo accordo, ma anche di recedere da esso in caso con preavviso di 6 mesi.
Nella sostanza il trattato di Kensington risulti essere in larga misura una lunga lista della spesa di cose in cui Regno Unito e Germania si impegnano a rafforzare la loro collaborazione bilaterale. Tuttavia, il trattato contiene una clausola di straordinaria importanza. L’articolo 3(4) infatti afferma che “consapevoli dello stretto allineamento dei loro interessi vitali, e convinti che non vi è minaccia strategica per una parte che non costituisca minaccia strategica anche per l’altra, le parti affermano in qualità di alleati vicini il loro profondo impegno alla difesa reciproca e si impegnano ad assistersi l’un l’altro, anche con mezzi militari, in caso di attacco ad uno di loro”. Questa disposizione introduce un patto di difesa reciproca tra Germania e Regno Unito, che riproduce a livello bilaterale il principio dell’Articolo 5 del Trattato NATO, rafforzandolo però con un obbligo ancora più giuridicamente vincolante di intervenire militarmente in difesa dell’alleato in caso di attacco da parte di una forza nemica. Il riconoscimento di una clausola di mutua difesa nel trattato tra Regno Unito e Germania espone la debolezza della Partnership sulla Sicurezza e la Difesa tra Regno Unito e UE, che invece non include nessun principio analogo. Questa mancanza, sulla quale mi ero criticamente soffermato in un precedente commento, mette in luce come l’UE abbia competenze limitate nel campo della difesa, e non costituisca dunque una controparte credibile laddove ci si debba impegnare a livello militare. Tuttavia, la conseguenza è che ciò che non è possibile giuridicamente e praticamente fare all’UE – ovvero impegnarsi a difendere reciprocamente un alleato – viene invece fatto da uno stato membro: la Germania, incidentalmente lo stato UE più grande, e quello che più avrà risorse per finanziare il proprio riarmo in linea con il programma Readiness 2030 lanciato dalla Commissione UE.
Se l’UE ha limitate competenze nel campo della difesa, invece, essa ha vasti poteri in altri settori, dall’economia, all’energia, alla tecnologia digitale, alla politica migratoria e la libera circolazione delle persone. E qui emerge l’altro aspetto problematico del trattato di Kensington. Sebbene l’accordo riaffermi in più punti l’impegno della Germania in qualità di stato membro dell’UE, e nonostante l’articolo 24 disponga esplicitamente che le disposizioni del trattato non possono in alcun modo intaccare gli obblighi della Germania in qualità di stato membro dell’UE, vi sono in realtà dei punti critici. Non solo varie disposizioni del trattato hanno a che vedere con materie che sono già regolate in dettaglio dall’Accordo di Cooperazione e di Commercio concluso tra Regno Unito e UE dopo Brexit, nella primavera 2021; ma altre ricalcano altresì nuove intese recentemente negoziate dal Regno Unito con l’UE nel suo complesso – incluso l’impegno di consentire l’uso da parte dei cittadini britannici dei sistemi elettronici di scansione dei passaporti quando entrano nell’area Schengen: sebbene l’articolo 18 preveda questa possibilità, in realtà questo è un tema su cui la Germania ovviamente non può decidere unilateralmente in quanto di competenza comunitaria. Da questo punto di vista il trattato incorre in un errore metodologico. Si ricorderà che subito dopo il referendum Brexit nel giugno 2016 il Regno Unito aveva cercato di imbastire una negoziazione bilaterale con alcuni importanti stati membri dell’UE. Ma questa strategia era stata giustamente rigettata dai 27, che invece avevano insistito per una negoziazione nella quale la Commissione rappresentasse tutta l’UE. Tale strategia aveva ampiamente pagato, consentendo all’UE di ottenere varie concessioni dai britannici. Ritornando ad una logica bilaterale, il rischio è di indebolire l’efficacia dell’azione dell’UE.
Insomma, il trattato di Kensington mette in luce ciò che l’UE ancora non può fare – tra cui impegnarsi in un patto di mutua difesa con il Regno Unito – ma evidenzia anche quello che unilateralmente gli stati membri non dovrebbero fare. Nonostante il comprensibile desiderio di alcuni paesi di rafforzare i loro legami bilaterali in un momento storico di grande incertezza, proprio Brexit insegna che gli stati membri dell’UE sono più forti quando agiscono nei confronti di paesi esterni come un’unione.
*Professore ordinario di diritto dell’UE presso la Dublin City University; Direttore Fondatore del Dublin European Law Institute

 It
It  En
En