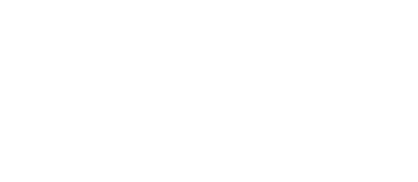Olimpia Fontana / 23 luglio 2025
Commento n. 004/2025 NS
La Commissione europea ha pubblicato la propria proposta di bilancio pluriennale dell’Ue, il Multiannual Financial Framework (MFF) per il settennato 2028-2034. Il pacchetto di proposte dà quindi il via ai negoziati che nei prossimi mesi riguarderanno il Parlamento europeo e il Consiglio, in un processo che si preannuncia molto difficile, viste le prime reazioni già espresse da attori coinvolti come regioni e agricoltori. Da parte sua, la Commissione propone un bilancio che intende essere: più ambizioso rispetto al passato, con una spesa totale che passa dall’1,1 all’1,26% del Pil dell’Ue, 1.980 miliardi di euro (corretti per l’inflazione prevista); più agile, con una maggiore capacità di adattarsi alle priorità; semplificato, riducendo il numero di programmi per diminuire sovrapposizioni e oneri amministrativi; più efficace, legando l’esborso delle risorse al conseguimento effettivo dei risultati.
In termini di dimensioni, il nuovo bilancio proposto formalmente aumenta rispetto al 2021-2027 (ovviamente escludendo i 700 miliardi di euro del NGEU). Tale aumento, però, incorpora la spesa per ripagare il debito del NGEU, quindi di fatto il bilancio futuro non si discosta molto da quello precedente, con un aumento di circa 60 miliardi di euro. In effetti, il nuovo MFF non solo deve far fronte a situazioni di forte necessità di spesa, ma coincide anche con l’inizio del periodo di rimborso del NGEU. Da una parte, in linea col Rapporto Draghi, viene enfatizzata l’importanza di rafforzare la spesa per la competitività e per la difesa, dall’altra si invita il Consiglio (i paesi membri) a iniziare a lavorare all’introduzione di nuove risorse proprie europee. La Commissione è esplicita nel dire che per non dover aumentare la componente dei contributi nazionali – fonte di entrata che i paesi membri versano al bilancio in base alla loro ricchezza economica – nuove risorse proprie europee devono essere introdotte.
Molti dei commenti alla proposta della Commissione hanno riguardato questioni sul lato della spesa. In particolare, sono stati criticati i National and Regional Partnership Plan, con cui ciascun governo nazionale negozierà con la Commissione su come usare i fondi assegnati, oppure l’accorpamento in un unico capitolo di spesa dei fondi per la coesione e per l’agricoltura. Poco si è detto sul tema fondamentale delle risorse proprie e sulla proposta di Decisione sulle risorse proprie, con cui di fatto la Commissione sollecita il Consiglio sull’introduzione di nuove risorse per il bilancio europeo. Non è un segreto che a seguito dell’Accordo Interistituzionale del dicembre del 2020 Commissione, Parlamento e Consiglio si erano impegnati a introdurre risorse proprie aggiuntive nel periodo 2021–2027. Grazie a questo impegno, è stato possibile dal 2021 garantire la copertura del debito del NGEU usato per finanziare la parte dei grants, i trasferimenti a fondo perduto concessi agli stati membri, mentre la parte dei prestiti viene rimborsata degli Stati membri stessi.
Nel 2021 e nel 2023 la Commissione ha riacceso l’attenzione, fornendo dettagli sulle possibili nuove entrate, con potenziali stime di gettito. Si tratta principalmente di risorse proprie collegate alla politica ambientale dell’Ue, ai profitti delle società, alle transazioni finanziarie. La logica è quella di colpire esternalità negative per la società, come le emissioni di CO2, l’elusione delle multinazionali, il dumping fiscale. Tuttavia, di tutte queste prime candidate, solo la risorsa propria basata sulla plastica ha visto la luce. Il resto delle proposte è stato posticipato (come le risorse ambientali) o definitivamente abbandonato (come la tassa sulle transazioni finanziarie).
La proposta che accompagna ora il MFF 2028-2034 comprende quindi vecchie e nuove candidate. Si confermano le risorse ambientali. Parte degli introiti che derivano dalla vendita dei diritti di emissione all’interno del mercato europeo del carbonio (Emission Trading System, ETS), confluirebbe al bilancio europeo: il 30% degli introiti generati dalle emissioni delle imprese energivore all’interno dell’Ue (risorsa legata all’ETS1) e il 75% degli introiti derivanti dalle emissioni incorporate in beni importati da Paesi extra-UE (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Queste due fonti, oltre a essere necessarie per sostenere la transizione ecologica, darebbero 11 miliardi di euro l’anno al bilancio europeo (1,4 miliardi di euro dal CBAM). Va notato che la precedente proposta di destinare anche i proventi dell’ETS2, il nuovo mercato del carbonio per il trasporto stradale e il riscaldamento degli edifici, è stata abbandonata dalla Commissione, lasciando quindi agli Stati tutti i proventi derivanti da questa misura. Un passo indietro, del resto in linea con il preoccupante rallentamento subito dal Green Deal nella seconda Commissione von der Leyen.
Le risorse più corpose sarebbero quella derivanti dall’e-waste (circa 15 miliardi), con cui ciascun paese dovrebbe versare al bilancio nazionale un ammontare corrispondete a 2 euro per kg di rifiuti non raccolti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e la risorsa sul tabacco (TEDOR), ovvero un 15% delle entrate nazionali derivanti dalle accise sul tabacco. La risorsa basata sulle società (CORE), applicata come importo forfettario annuale sui ricavi, permetterebbe di raccogliere 6,8 miliardi di euro. Ulteriori 14 miliardi deriverebbero da vari aggiustamenti alle attuali risorse proprie, per un totale di 58 miliardi l’anno. Se e-waste e TEDOR vanno nella giusta direzione, colpendo esternalità negative e incentivano cambiamenti comportamentali (proposte simili potrebbero riguardare risorse proprie sul gioco d’azzardo, sul gender pay gap, sul food waste), la proposta CORE appare un prelievo iniquo per le aziende più piccole e in contrasto con le politiche per la competitività.
Un elemento fondamentale della proposta riguarda prevedere l’istituzione di un nuovo strumento straordinario e temporaneo, da usare in ultima istanza in caso di gravi crisi. Questo crises mechanism ammonterebbe a 395 miliardi di euro (addizionali rispetto al 1,26% del MFF) e verrebbe finanziato con l’emissione di titoli di debiti europeo per fornire prestiti agli stati membri, che dagli stai membri dovranno essere ripagati. In pratica, un secondo NGEU ma privo della componente dei grants, proprio quella che dal 2028 graverà sul MFF per 24 miliardi l’anno. La Commissione si mostra quindi molto cauta nel proporre debito comune europeo, chiedendo che il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento sia portato all'1,75%, di cui uno 0,25% da destinare esclusivamente per la copertura di tutte le passività derivanti da questo scudo contro le crisi. Va tuttavia ricordato che l’uso di debito europeo per finanziare prestiti è già stato usato con successo durante la pandemia con SURE per la cassintegrazione (100 miliardi) e di recente è stato previsto per la difesa con SAFE (150 miliardi). Si tratta di forme di assistenza finanziaria per consentire agli stati membri di finanziarsi a condizioni più favorevoli sul mercato.
In definitiva, le proposte della Commissione sul lato delle entrate cercano di rianimare un dibattito che è rimasto sopito a lungo da parte degli Stati membri. Il livello di ambizione mostrato dalla Commissione non è elevato e avrebbe potuto avanzare altre possibili candidate per le risorse proprie, come richiesto dal Parlamento europeo. Tuttavia, vi sono paesi come Germania e Olanda, che pur essendosi detti favorevoli a nuove risorse proprie, sono contrari ad aumenti di bilancio. In sostanza, considerano le risorse proprie come la via per ridurre i propri contributi nazionali. La logica del giusto ritorno continua così a prevalere, mentre andrebbe combattuta facendo leva sulla narrativa dei beni pubblici europei, sull’evidenza che una maggiore spesa comune per politiche di carattere strategico (doppia transizione, ricerca e innovazione, difesa) andrebbe a beneficio di tutti i paesi. Ma questo richiede un aumento significativo del bilancio, non lo status quo.
*Senior Visiting Fellow FCSF

 It
It  En
En