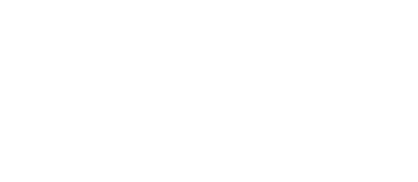Martina D'Andrea / 20 giugno 2025
Commento n. 003/2025 NS
Il ciclo di seminari dal titolo «L’Unione europea: una bussola in un mondo in tempesta?», organizzato dall’Università di Milano e dalla Fondazione CSF, è stata una preziosa occasione per riflettere su alcuni temi che coinvolgo l’Unione europea e il processo di integrazione, in un periodo storico caratterizzato da profondi sconvolgimenti come i conflitti armati e i cambiamenti climatici e le crescenti tensioni economiche a livello globale, alimentate dalle scelte protezionistiche dell’amministrazione statunitense.
Attraverso i nove incontri sono stati trattati molti argomenti, alcuni dei quali particolarmente urgenti all’interno dell’agenda europea, ma la maggior parte dei relatori ha sottolineato come questi temi stiano sollecitando la tenuta delle istituzioni dell’Unione, soprattutto in quelle materie dove l’accordo richiede un’ampia convergenza di vedute (se non l’unanimità) e gli egoismi nazionali sembrano prevalere. Prendendo ad esempio solo tre dei tanti argomenti trattati – difesa, transizione verde e immigrazione – si vedrà come il processo decisionale dell’Unione è stato – ed è, in alcuni casi – lento e difficile, anche a causa della tendenza degli Stati a proteggere i propri interessi. La scelta di focalizzarsi su tali tematiche non è casuale: benché ad ognuna sia stato dedicato un seminario specifico, alcuni temi sono stati riproposti, sotto diversi punti di vista, anche in altri incontri. È indubbio, ad esempio, che non si possa discutere del posizionamento economico globale e del futuro dell’Unione, senza prima riflettere sullo stato di salute dell’industria della difesa, considerando anche il conflitto armato in corso nel territorio europeo.
Nell’ambito delle riflessioni proposte sul tema è emerso, però, che gli interessi economici tendono a prevalere sulla necessità di un coordinamento sovranazionale in materia di difesa. Le minacce all’Europa (soprattutto da Est) non possono essere affrontate senza una politica comune, che non si tradurrebbe in una cessione del controllo degli esciti nazionali da parte degli Stati, bensì nella messa in comune di mezzi, saperi, esperienze e tecnologie per strutturare un sistema integrato e, soprattutto, per raggiungere quel coordinamento strategico (di cui parlava il Gen. Vincenzo Camporini) fondamentale nei teatri di intervento comune degli eserciti europei.
Anche la transizione ecologica è un tema che attraversa trasversalmente tutti i seminari, in quanto i cambiamenti climatici e l’inquinamento hanno un impatto notevole sia sull’economia che, soprattutto, sulla qualità della vita dei cittadini europei. Per questo motivo l’Ue si è imposta una tabella di marcia molto serrata per attuare politiche pubbliche di conversione della produzione di energia e di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità. Ma anche in questo ambito gli Stati si mostrano divisi tra quelli (soprattutto dell’Est Europa) che impiegano molti lavoratori nel settore dei combustibili fossili e che riescono a produrre una grande quantità di energia per i loro fabbisogni interni, altri (come la Francia e la Polonia) che spingono per un passaggio rapido al nucleare e altri ancora (come la Germania) i quali temono, invece, che l’energia nucleare sia troppo rischiosa e sostengono la conversione totale alle fonti di energia rinnovabili. Anche in questo caso, dunque, sembra che gli Stati siano divisi lungo linee di interessi economico-sociali, con uno sguardo poco lungimirante e ristretto ai confini nazionali.
Un tema forse meno trasversale, ma le cui riflessioni conclusive legano gli argomenti affrontati negli altri incontri, è quello della politica migratoria.
Nel seminario dedicato al futuro del principio solidarista è stato messo in luce come da anni l’Unione europea stia discutendo di un meccanismo equo di redistribuzione dei migranti: dopo due (falliti) tentativi di riformare il regolamento di Dublino in tal senso (nel 2016 e nel 2018), nel 2024 si è giunti all’approvazione del nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo, all’interno del quale, però, non è ancora previsto un meccanismo di ricollocazione obbligatoria che impegni in maniera solidale tutti gli Stati membri. Ad essi, infatti, è rimessa la scelta sul “come” essere solidali, potendo optare per l’accoglienza materiale delle persone sul proprio territorio oppure per una contribuzione finanziaria in favore dei Paesi sotto pressione migratoria.
Partendo da queste ultime riflessioni sulle politiche migratorie è possibile ricollegarsi ai temi sopra richiamati, verificando come nelle questioni che coinvolgono più direttamente la solidità istituzionale dell’Unione – e quindi il suo futuro, sia da un punto di vista interno che esterno – ciò che sembra venire meno è proprio la solidarietà tra Stati, che – ricordiamo – è un principio di rango costituzionale (in virtù degli articoli 2 e 3 TUE e 67, 80 e 222 TFUE).
Gli egoismi nazionali, dunque, prevalgono proprio laddove è più forte il bisogno di una visione condivisa del futuro dell’Unione e di come essa debba affrontare le sfide che ha davanti, ostacolando così l’adozione di normative efficaci e decisioni rapide.
D’altronde, come Mario Draghi ha avuto modo di affermare, l’Europa è troppo piccola per pensare di competere sulla scena globale senza una visione comune, se non ritrova lo «spirito unitario» delle origini. Ma già Robert Schuman, nella sua celebre dichiarazione del 9 maggio 1950, parlava di una «solidarietà di fatto», necessaria allo sviluppo del progetto federalista europeo.
Ciò che accende un faro di speranza per il futuro, è l’esperimento che l’Unione europea ha compiuto con il Next Generation EU, il quale può essere considerato come un valido esempio di solidarietà comunitaria.
Con questa importante iniziativa l’Unione europea ha saputo rispondere alla più grave crisi degli ultimi decenni, che ha sconvolto l’Europa e il mondo intero: la pandemia da Covid-19. Sospendendo temporaneamente il Patto di stabilità e crescita e dando applicazione a quanto previsto dall’art. 122 TFUE, l’Ue è stata in grado di reperire risorse comuni sul mercato finanziario e ridistribuirle agli Stati membri in funzione dei danni subiti, configurando un nuovo modello di governance centralizzata, nel quale il dialogo tra la Commissione europea e gli Stati membri è costante e proficuo, con un coinvolgimento diretto (benché ancora marginale) dei parlamenti nazionali. A metà tra metodo comunitario e metodo intergovernativo, all’interno della cornice disegnata dal NGEU sembrano presenti molti tratti di quella solidarietà di fatto tanto richiamata, evidenziando come, ancora una volta, l’Unione europea abbia saputo compiere grandi passi in avanti sul cammino dell’integrazione sfruttando un momento di grave crisi, facendo della coesione il proprio punto di forza.
È necessario allora recuperare quello spirito collaborativo che gli Stati membri hanno sempre fatto emergere durante le crisi, affinché possa diventare parte integrante del nuovo metodo di governo comunitario, con il quale affrontare un futuro carico di incertezze e di sfide epocali per l’Unione europea e non solo.
*Junior Visiting Fellow FCSF

 It
It  En
En