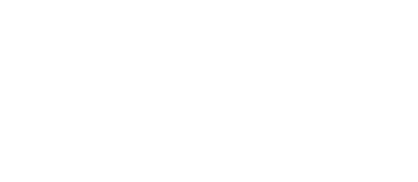Albertina Nania / 14 ottobre 2025
Commento n. 012/2025 NS
Quando la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, invita i governi a “buckle up for a world of more turbulence”, il messaggio è tutt’altro che retorico. Arriva alla vigilia degli Annual Meetings 2025 del Fondo e della Banca Mondiale (Washington, 13-18 ottobre 2025), in un contesto segnato da tensioni geopolitiche, riallineamenti commerciali e una fiducia globale ancora fragile.
L’idea che si possa tornare a una “normalità” pre-pandemica si rivela illusoria: l’economia globale non oscilla più tra crisi e ripresa, ma evolve dentro un regime di turbolenza permanente, dove la volatilità diventa una componente strutturale, non più un fenomeno episodico. Negli ultimi anni, la globalizzazione ha mostrato la propria fragilità: le catene del valore, un tempo orientate alla massima efficienza, sono oggi riconfigurate secondo logiche di sicurezza e sovranità. La frammentazione commerciale e tecnologica, accelerata dalla competizione strategica tra Stati Uniti e Cina, erode i benefici dell’integrazione economica e introduce nuovi costi strutturali. Il cosiddetto friend-shoring — spostamento delle produzioni verso paesi affidabili — riduce alcune vulnerabilità ma moltiplica le inefficienze, accentuando la regionalizzazione dei mercati e la duplicazione delle infrastrutture produttive.
Il Fondo sottolinea che questa riorganizzazione, se non accompagnata da nuove regole multilaterali, rischia di trasformarsi in una forma di “decoupling competitivo” capace di ridurre la produttività globale e alimentare tensioni inflazionistiche di lungo periodo.
Sul fronte finanziario, la dinamica del debito pubblico costituisce un ulteriore elemento di rischio. Dopo anni di politiche espansive e tassi prossimi allo zero, molti paesi si trovano ora con margini fiscali estremamente ridotti. Il FMI richiama l’attenzione su un punto cruciale: l’apparente stabilità ottenuta grazie a condizioni monetarie accomodanti non equivale a sostenibilità di lungo termine. Una normalizzazione dei tassi o un deterioramento del clima geopolitico potrebbe rapidamente compromettere la fiducia degli investitori e riaccendere crisi di liquidità.
In tal senso, la vulnerabilità del debito sovrano assume una dimensione geopolitica, poiché la capacità di finanziarsi sui mercati internazionali è ormai parte integrante della sicurezza economica nazionale.
A questo quadro si aggiunge la rivoluzione dell’intelligenza artificiale, fattore ambivalente di crescita e disuguaglianza. L’IA promette un incremento significativo della produttività, ma rischia di concentrare il valore aggiunto in pochi poli tecnologici, accentuando la distanza fra economie dotate di capacità digitale e quelle che ne restano ai margini. Senza un’azione pubblica mirata — formazione, riqualificazione, protezione del lavoro cognitivo — l’automazione potrebbe amplificare la polarizzazione sociale e rendere più fragile la coesione interna. In prospettiva, la sfida non sarà soltanto quella di “adottare” le nuove tecnologie, ma di governarle politicamente, definendo regole etiche eque e sistemi fiscali in grado di redistribuire i benefici dell’innovazione.
Il monito del Fondo Monetario Internazionale assume così una valenza strategica: non è soltanto una diagnosi di fragilità, ma una chiamata a ridefinire la governance economica globale. Le ricette tradizionali — stimolo monetario, espansione fiscale, deregulation — non bastano più in un contesto di shock multipli e interdipendenze complesse. È necessario costruire nuovi meccanismi di coordinamento e cooperazione, rafforzando gli organismi multilaterali e adattandoli alla realtà di un ordine mondiale multipolare.
In questo senso, il ruolo del FMI non può limitarsi a quello di “sorvegliante” macroeconomico, ma deve evolvere verso una funzione più proattiva di intelligence economica globale, capace di anticipare i rischi sistemici e orientare le politiche verso la resilienza collettiva.
Per l’Europa, il messaggio è particolarmente rilevante. La dipendenza da forniture strategiche esterne, la transizione energetica ancora incompleta e la frammentazione del mercato dei capitali rendono l’Unione vulnerabile agli shock esterni. Tuttavia, la dimensione europea offre anche l’opportunità di sperimentare un modello alternativo di sviluppo: un’economia aperta ma protetta, competitiva ma socialmente coesa.
Investire nella sovranità industriale, potenziare i partenariati tecnologici interni e promuovere strumenti comuni di stabilizzazione finanziaria sono passaggi indispensabili per tradurre il principio di “autonomia strategica” in realtà operativa.
In definitiva, l’invito di Georgieva a “buckle up” non è un esercizio di pessimismo, ma un appello al realismo. L’economia mondiale entra in una fase in cui la gestione dell’incertezza diventa la principale competenza strategica. Non si tratta più di prevedere le crisi, ma di costruire sistemi capaci di assorbirle senza implodere. In questo scenario, la forza di un paese o di un’area economica non si misura più solo dal PIL o dal saldo commerciale, ma dalla capacità di preservare coesione, flessibilità e autonomia decisionale in un ambiente globale sempre più frammentato.
Chi saprà investire in resilienza strutturale, cultura del rischio e lungimiranza istituzionale potrà affrontare con successo l’era della turbolenza permanente. Gli altri, semplicemente, ne subiranno gli effetti.
*Junior Visiting Fellow Fondazione CSF

 It
It  En
En